La descrizione di un anno di attività e servizi in favore di richiedenti asilo e rifugiati
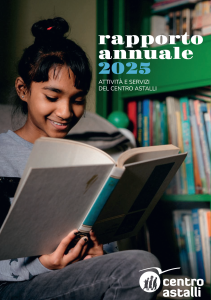 Il Centro Astalli presenta una fotografia aggiornata sulle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati che durante l’anno si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati e hanno usufruito dei servizi di prima e seconda accoglienza che l’organizzazione offre. Il commento di P. Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, sull’anno trascorso.
Il Centro Astalli presenta una fotografia aggiornata sulle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati che durante l’anno si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati e hanno usufruito dei servizi di prima e seconda accoglienza che l’organizzazione offre. Il commento di P. Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, sull’anno trascorso.
Rifugiati: lo sguardo lungo dei diritti
Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile, attraversato da policrisi, “impazzito”, se prendiamo in prestito una definizione – certo non geopolitica – usata da qualche leader e commentatore.
Consideriamo solo alcune questioni che si sono verificate su scala globale. Sono andati al voto 76 Paesi, Russia, India, Stati Uniti, più quelli europei (per citarne solo alcuni), vale a dire il 51% della popolazione mondiale. I risultati, in certi casi sono stati in linea con quanto atteso, in altri hanno avuto un andamento sorprendente; certamente in molti Paesi non si è trattato di consultazioni libere.
I conflitti sono proseguiti con escalation e continui rischi di allargamenti territoriali (pensiamo al Medio Oriente), ma anche con barlumi di speranza per una possibile risoluzione.
La COP29 sul clima ha dato risultati non all’altezza del pericolo che stiamo correndo. Tali eventi fanno da sfondo al fenomeno della mobilità umana forzata, che secondo i dati dell’UNHCR a giugno riguardava oltre 122 milioni di persone, con un aumento di circa il 10% rispetto all’anno precedente (un numero in continua crescita da 12 anni a questa parte), in particolare a causa delle crisi in Sud Sudan e Ucraina.
I nuovi sviluppi della situazione nel Medio Oriente, con la caduta e la fuga del Presidente Bashar al Assad dalla Siria e il fragile cessate il fuoco in Libano e Palestina
(tregua appena interrotta mentre questo Rapporto va in stampa), fanno supporre che gli scenari saranno più fluidi, ma che certo il quadro non si modificherà sostanzialmente nel prossimo futuro.
Sul versante europeo, il 2024 è stato l’anno del Patto sulla migrazione e l’asilo adottato dal Consiglio europeo a maggio. Salutato come un grande passo avanti per la gestione dei flussi migratori, si tratta piuttosto di un arretramento del diritto d’asilo su più fronti, come hanno evidenziato varie realtà della società civile che si occupano di rifugiati. In un comunicato di aprile, l’ufficio europeo del Jesuit Refugee Service affermava: Preoccupa soprattutto il rischio di detenzioni arbitrarie e automatiche […] le persone si troveranno in procedure molto complicate, spesso detenute, senza un’adeguata assistenza legale […] il “meccanismo di solidarietà” del Patto non è sufficiente a garantire l’impegno di tutti gli Stati membri dell’UE a condividere la responsabilità di proteggere i rifugiati. I Paesi di primo ingresso nell’UE rimarranno perlopiù responsabili dell’esame delle domande di asilo, mentre non vi è alcun obbligo e pochi incentivi per gli Stati membri che non si trovano alle frontiere a ricollocare i richiedenti asilo. Avere un unico sistema d’asilo europeo che unifichi le procedure per l’accesso alla protezione internazionale è di per sé auspicabile per risolvere la discrezionalità dei singoli Paesi rispetto a un istituto così importante. Tuttavia, nel caso del Patto lo si è piegato a una logica dissuasiva per chi arriva, considerato fin da subito come irregolare e quindi in prima istanza come un “non avente diritto”, mettendo in atto un respingimento di fatto. Questa modalità dissuasiva nel tempo è stata supportata da una serie di istituti: la detenzione fuori e dentro i confini dell’Europa, la deportazione, il rimpatrio coatto, rendendo traumatizzante per i migranti forzati, non solo il viaggio, ma lo stesso accesso alle procedure d’asilo.
Anche in Italia la politica sull’immigrazione ha continuato a essere quella di contenimento.
Il 2024 ha visto l’apertura dei centri di detenzione in Albania, frutto di un protocollo tra il Governo Italiano e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania, sottoscritto a fine 2023 e divenuto legge nel febbraio del 2024 (legge 21 febbraio 2024, n. 14). Lo scopo sarebbe quello di portare i migranti originari di Paesi definiti “sicuri”, intercettati in acque internazionali (per un numero massimo di 3.000 persone contemporaneamente) dalle navi militari direttamente in Albania (Paese extraeuropeo), per la valutazione delle domande di protezione internazionale (sono escluse da questa procedura le persone vulnerabili). I centri in Albania avrebbero dovuto essere attivi a partire da maggio, ma la consegna è stata posticipata a ottobre. Da allora, nonostante alcuni simbolici trasferimenti, i trattenimenti (fino a oggi) non sono mai stati convalidati dai tribunali italiani competenti, in attesa di una sentenza della Corte di Giustizia europea che chiarisca alcuni aspetti circa la definizione e l’applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”. Tale procedura, a prescindere dallo spreco di soldi pubblici, evidenziato da più parti, dal dubbio profilo di costituzionalità e dal conflitto tra poteri dello Stato che ha innescato, rappresenta un chiaro attacco al diritto d’asilo, teso ad indebolirlo, e tende sempre più a legittimare presso l’opinione pubblica il concetto di deportabilità delle persone migranti, minandone la dignità.
Come Centro Astalli abbiamo dovuto far fronte a questo nuovo contesto che rende sempre più difficile il lavoro con le persone rifugiate per svariati motivi. Innanzitutto, i migranti che arrivano sul territorio italiano sono sempre più spesso vulnerati da tentativi negati di accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, che comportano detenzioni e violenze aggiuntive, e dal tempo sospeso a cui li costringe un’attesa che dura mesi (quando non anni) per vedere, eventualmente, riconosciuta la loro domanda. I percorsi di inclusione si scontrano sempre più spesso contro l’ostacolo di una opinione pubblica piegata alla propaganda, che fa dei migranti dei nemici. Lo scorso anno ci ha visti particolarmente impegnati in azioni di sostegno all’autonomia abitativa che hanno portato a una piccola pubblicazione sul diritto all’abitare, Contro muro. Non si è trattato di un vademecum su come muoversi nella giungla del mercato immobiliare, quanto piuttosto della raccolta di testimonianze di rifugiati e rifugiate, rivelatrici degli ostacoli burocratici, economici e sociali che incontrano cercando casa. Un punto di vista altro, consapevoli che l’abitare e il coabitare sono azioni civili di creazione di comunità.
Siamo sempre più convinti che il tema migratorio vada affrontato coinvolgendo tutti gli attori che giocano un ruolo in questo processo, l’intera comunità e le comunità dei diversi Paesi. Non si tratta di un fenomeno che si scatena su di un territorio come fosse un evento climatico avverso improvviso, ma piuttosto di un processo che va regolamentato e inserito in una pianificazione globale, come aveva previsto il Patto globale per una migrazione ordinata sicura e regolare, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre del 2018. Opporsi a questo fenomeno, come si sta facendo in molte parti del mondo, e utilizzarlo per altri fini politici non favorisce una sua adeguata regolamentazione, anzi, pone le basi per una conflittualità locale e internazionale che può avere delle gravi conseguenze. Ecco perché in questo Anno Giubilare il nostro auspicio è che segni di speranza possano generare sguardi lungimiranti e aprire cammini nuovi.
P. Camillo Ripamonti sj
Presidente Centro Astalli
Scarica il Rapporto annuale 2025
Sintesi del Rapporto annuale 2025

